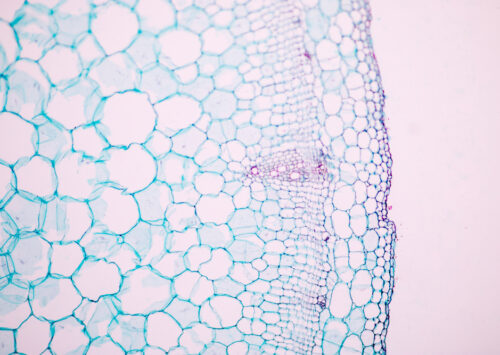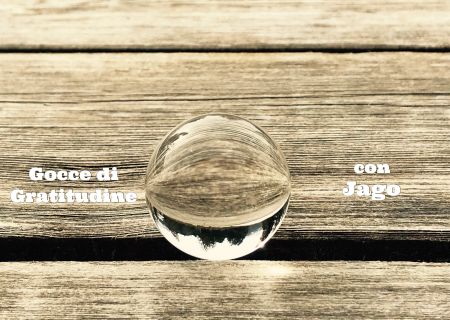Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendo la spaccatura con dell’oro. Li muove una convinzione radicata nella loro cultura secolare: quando qualcosa che ha una storia subisce una ferita, la storia di quella cosa diventa più bella sia nella sua forma che nella sua sostanza.
Questa tecnica è chiamata Kentsugi.
Anche la storia di una persona che ha sofferto può essere resa più bella e preziosa da una tecnica. Questa tecnica si chiama Amore.
Quando nella mia vita ho sofferto, è stato spesso più semplice cercare di rifugiarmi fuori di me in cerca di qualcosa o qualcuno in cui trovare ristoro o, peggio, da responsabilizzare per il mio dolore, piuttosto che indagare dentro. Ho così osservato che raramente questo atteggiamento è stato risolutivo della mia sofferenza. Nella nostra sofferenza la prima persona da amare siamo forse proprio noi stessi, e così anche il dolore magicamente si trasforma in un intenso percorso di auto-conoscenza.
Il dolore è auto-conoscenza.
Tutte le volte che non c’è comprensione grazie al dolore, la sofferenza ci ancora al passato, alla mancanza di una cosa che prima c’era e ora invece non c’è più perchè ne siamo stati privati. Lo so, è strano, perché è come dire che adesso, qui e ora, quella cosa in realtà non c’è …e basta!, e questo è ben diverso dal non esserci perchè non c’è più.
E’ come dire che l’unica comprensione della sofferenza risiede nella nostra capacità di restare nell’attimo. Nell’attimo non c’è più ieri e non c’è ancora domani; anzi, non c’è mai stato ieri (tanto meno mi può mancare qualcosa dello ieri) così come non c’è ancora domani (tanto meno ciò che temo che domani possa mancarmi).
Il dolore in realtà fa sostanzialmente una cosa: ti desta, ti richiama, ti lascia un segno, ti in-segna. Ti insegna che sei vivo. Poi passa e ti lascia cambiato. A volte ti lascia più saggio, a volte più forte. Una vera rivoluzione, un vero ribaltamento.
La sofferenza, non importa se fisica, emotiva o intellettuale, è oggettivamente sempre legata a una memoria.
Qualcosa che c’era e di cui siamo stati privati, un affetto, un’idea, una persona, una cosa. La ricerca neuroscientifica (così come condiviso anche da Moshe Bar – noto neuroscienziato israeliano – in occasione della quinta edizione di “21min” tenutasi ad Assisi a novembre 2013) ha dimostrato che noi siamo solo ed esclusivamente ciò che ricordiamo, cioè le nostre memorie . E siccome, come diceva Bar, “…le memorie sono solo delle ricostruzioni della realtà”, la realtà continuerà ad essere una semplice proiezione all’esterno che ciascuno fa del proprio mondo interiore.
“La mente prefigura sempre un domani”, proseguiva Moshe Bar, ma quel domani, ora, qui, adesso, ancora non c’è. E quel tipo di domani mai ci sarà. Scompare ‘ieri’ e mai arriva ‘domani’. La vita si riduce così al qui e ora. E tutto perde potere su di me.
C’è invece un’essenziale capacità da produrre nella nostra vita, ed è quella che il Dott. Patrizio Paoletti ha coniato col termine Inner Design Technology: un costante rimodellamento del nostro mondo interiore, attimo dopo attimo, istante dopo istante, qui e ora dopo qui e ora, in cui ridurre a zero la distanza tra il disegno proiettivo fatto dal proprio cervello e la realtà.
Il mondo non ci educa all’importanza e alla centralità dell’attimo bensì ci costringe a una polarizzazione tra passato e futuro, tra ciò che c’era e non c’è più (che spesso genere dolore, sofferenza, recriminazione) e ciò che desidereremmo ci fosse domani. Ma questo domani non arriva mai perché questo domani in realtà non esiste (ancora); e non può esistere perché (ancora) non c’è.
La vita diventa così un frenetico oscillare tra ieri e domani senza mai restare nell’oggi, nell’ora. Se domani non esiste, un’unica, imprescindibile, domanda sorge allora dal profondo del mio essere: “Qual è il senso ultimo del mio destino?”