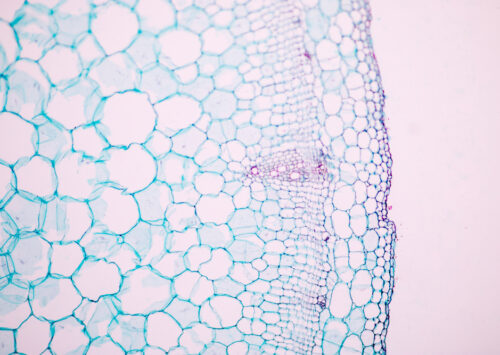Nel suo saggio La macchina delle verità. Come Google e i Big data ci mostrano chi siamo veramente, pubblicato in Italia lo scorso ottobre, il data scientist ed editorialista del New York Times Seth Stephens-Davidowitz, ci dice che se vogliamo conoscere la verità su una persona dobbiamo privilegiare l’analisi dei dati risultanti dalle ricerche che ha effettuato con Google e invece diffidare di quelli che ha seminato su Facebook e sugli altri social network.
Stephens-Davidowitz, che ha studiato filosofia a Stanford, economia ad Harvard ed è stato a lungo data analyst in Google, ritiene che questo accade perché le persone mentono, sempre e comunque, quando si trovano in un contesto sociale in cui le proprie informazioni personali, come le idee politiche, lo stato di salute o le preferenze sessuali, possono determinare giudizi negativi. E, più in generale, perché tutti tendiamo a voler risultare presso i nostri amici, parenti, colleghi di lavoro e superiori, migliori di quanto in realtà non siamo: più intelligenti, più sani, più sportivi, più felici o più innamorati.

Questa dinamica di competizione migliorativa dell’immagine di noi stessi invece non si innesca quando utilizziamo la rete per soddisfare le nostre curiosità. Quando appunto usiamo Google per lo scopo per il quale è stato creato: conoscere il mondo e trovare le risposte ai nostri quesiti, finiamo con il rivelare fin troppo di noi a causa delle tracce che lasciamo e che vengono comunque tracciate, conservate e analizzate. Un mare magnum di informazioni nelle mani di aziende, pubbliche amministrazioni, partiti politici e così via, a cui bastano poche domande ben poste, e per questo ci sono i data analyst, per metterci nel loro mirino. Ma con quale criterio veniamo valutati?
Io sono fermamente convinto che un principio cruciale della nostra vita è essere consci della complessità insita nel tentativo di comprendere l’altro. Spesso sbagliamo perché abbiamo ridotto il nostro interlocutore, il nostro “altro” al più detestabile aspetto della sua persona mentre invece dovremmo guardarlo nella bellezza della sua complessità e nella molteplicità delle sue manifestazioni. Penso che dovremmo venire educati alla sensibilità che è quella qualità che ci mette nella condizione di entrare in relazione con l’altro riconoscendolo come un altro me stesso, anziché essere distorti dall’intolleranza che ci induce a vedere in lui la diversità.
È proprio la complessità del nostro mondo sempre più dilaniato da tensioni sociali oltre che da crisi economico-valoriali, che ci richiede di manifestare questa nuova abilità, ora. Dobbiamo iniziare ad esprimere un più alto livello di ascolto e maturare nuove comprensioni sapendo riconoscere tutta la ricchezza che c’è nella diversità. O noi impariamo subito a convivere nella differenza, ma non nell’indifferenza, o presto diventeremo dei barbari.