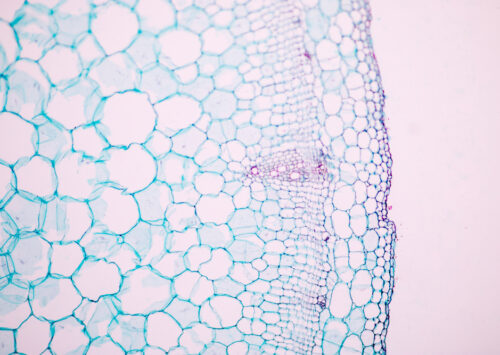Al giorno d’oggi siamo impegnati a comunicare senza sosta ma di rado capita di domandarci: sto dicendo veramente quello che voglio dire? Non siamo di certo i primi: da sempre nella storia anche i più grandi e rivoluzionari pensatori hanno dovuto fare i conti con il contesto storico, le pressioni sociali, le censure. Non a caso lo scrittore e giornalista George Orwell scrisse: “Se la libertà significa qualcosa allora è il diritto di dire alla gente quello che non vuole sentire“.
Oggi comunichiamo in continuazione. Eppure è raro che diciamo esattamente quello che ci sentiremmo di dire. Vogliamo sempre fare la battuta più brillante su Twitter, corriamo a esprimere la nostra opinione sul fatto del giorno, magari senza esserci informati opportunamente, ci facciamo mille scrupoli e così via. Ecco che le nostre parole vengono distorte, perdono di sincerità, spontaneità ma soprattutto di connessione col reale. Basti pensare a quante volte sorge il dubbio che i media o certi personaggi pubblici si esprimano in un modo che non è esattamente trasparente o fedele ai fatti.
Siamo d’altronde in quella che Oxford ha definito era della “post-verità”. Gli alternative facts di cui si è parlato ultimamente negli Stati Uniti di Trump sono un bell’esempio di come anche il linguaggio possa essere piegato a originare contraddizioni fino a poco tempo fa impensabili: i fatti erano fatti, senza alternative. I giornalisti incorruttibili, i profeti scomodi, i difensori del libero arbitrio sembrano martiri degni solo di vecchi film di Hollywood.
Le bolle in cui ci immergono i social o i mezzi digitali funzionano invece in un modo autoreferenziale e al contempo pericoloso: ci piacciono perché siamo esposti solo a opinioni che corrispondono al nostro modo di vedere, leggiamo solo cose che ci compiacciono, ma che ci tagliano anche fuori da una parte di società e cultura che la pensa diversamente da noi. È questo il terreno in cui proliferano le fake news, piaga apicale del nostro tempo, difficili da smontare senza esporsi ad altre fonti di informazione. È così che evitiamo di andare a fondo nelle cose, a recuperare un senso della dimensione reale.
Il politicamente corretto, la paura di offendere, un’isteria legata a ciò che va detto e cosa no limitano la libertà di espressione in un’epoca in cui essa è virtualmente al suo massimo. D’altronde è più comodo così: “Per farsi dei nemici non è necessario dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa”, diceva Martin Luther King.
Se persone come lui si sono sacrificate in nome della libertà forse vuol dire però che questi sono principi che non riguardano solo l’opportunità personale, sono invece veri e propri valori culturali. Al contrario stiamo perdendo l’attaccamento alla realtà fattuale delle cose e anche l’inclinazione ad accettare la verità, anche quando è scomoda.
Mentre è sempre più facile cadere nelle trappole della propaganda o della disinformazione, sarebbe opportuno correre dei rischi. Non esprimerci solo in modo da ottenere qualche like in più o con mille cautele per non disturbare i poteri forti o i prepotenti di turno. In una recente intervista lo scrittore Eric Emmanuel Schmitt scriveva che siamo “un’epoca vittimistica, in cui non facciamo altro che definirci vittime di qualcosa o qualcuno”.
Ecco, essere meno vittime forse passa proprio dall’alzare un po’ più la voce. Sempre con rispetto, ma anche tanta determinazione.