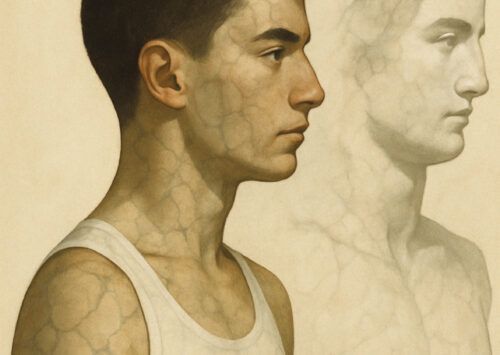“Sventurata la terra che non ha eroi” dice il discepolo Andrea, dopo aver sentito un banditore leggere l’abiura resa da Galileo all’Inquisizione. “No – replica Galileo – sventurata la terra che ha bisogno di eroi”.
Per quanto questa battuta del dramma brechtiano “Vita di Galileo” sia stata nel tempo infinitamente citata, a volte sopravvalutata altre sottovalutata e in taluni casi addirittura avversata, in questo mi pare utile a rappresentare due facce di una stessa storia. E per quanto possa sembrare esageratamente azzardato accostare la figura di un vecchio scienziato che dell’eroico ha avuto giusto l’ardire di rivoluzionare la scienza, a quello di un giovane calciatore che ha dalla sua giusto qualche gol e un brutto trauma che protegge con una mascherina, in realtà azzardato non è. Perché? Per via che tutti e due, ciascuno per la propria sfera di interesse, hanno la propria missione. Victor Osimhen si è presa sulle sue spalle quella di rivoluzionare lo spirito di una città.

 E difatti, sebbene l’obbligo sanitario di indossarla quella mascherina fosse cessato oramai da tempo, l’attaccante nigeriano non l’ha voluta abbandonare, anzi ha continuato a sfoggiarla con una sicurezza sempre più evidente. È come la coperta per Linus, si è detto, evidentemente il trauma deve essere stato grave e saggiamente l’atleta si mantiene protetto. È diventato un amuleto, si è letto poi, oramai quella mascherina porta fortuna.
E difatti, sebbene l’obbligo sanitario di indossarla quella mascherina fosse cessato oramai da tempo, l’attaccante nigeriano non l’ha voluta abbandonare, anzi ha continuato a sfoggiarla con una sicurezza sempre più evidente. È come la coperta per Linus, si è detto, evidentemente il trauma deve essere stato grave e saggiamente l’atleta si mantiene protetto. È diventato un amuleto, si è letto poi, oramai quella mascherina porta fortuna.
Ma che fosse per tutela fisica o per pura scaramanzia poco importa, indossandola partita dopo partita, gesto atletico dopo gesto atletico, ha fatto nascere e ha nutrito uno degli elementi simbolici più potenti dei nostri giorni. E non solo perché rappresenta a tutti gli effetti l’indimenticabile stagione calcistica di una squadra di campionato che attendeva di vincere da un trentennio, 33 anni per la precisione. Cosa che di per sé avrebbe già un significato assoluto. Ma anche perché ha travalicato lo spazio evidentemente troppo risicato dello stadio per dilagare nell’altrove. In ogni altrove. Dalle bancarelle sulle quali ovviamente hanno fatto e fanno sfoggio di sé, esercitando l’antica arte del merchandising, alle vetrine delle pasticcerie. Perché si sa, a Napoli quel che non manca è la creatività, la fantasia.

Non è per il denaro, certo anche quell’aspetto conta, è per la capacità tutta teatrale di mettere in scena la storia racchiudendola in un simbolo alla portata di tutti, e facendo sì che la scena non sia solo quella oltre le classiche tende di velluto pesante, ma esondi e debordi nelle piazze, nelle strade, nei vicoli e sui balconi, che contagi con la propria gagliardia ogni angolo, ogni crocicchio in cui vi siano anime viventi, che dia forma e colore a ogni panno steso al sole, che stia sulla punta della lingua di ogni singolo concittadino. Perché qui non si tratta dei tifosi di una squadra di città, si tratta dell’intera città. Un’intera città che per metonimia, complice una iconica mascherina, imita e celebra all’infinito chi è stato in grado di regalare una gioia insperata e così lungamente attesa.
Napoli aveva bisogno di Osimhen? Sì, se pensiamo come nel dramma brechtiano che una terra che non esprima eroi sia sfigata, vuota di prospettive e di slanci, priva di motivazione e di collante sociale. No, se al contrario riteniamo che società moderne, strutturalmente avanzate e culturalmente solide ne debbano fare a meno perché bastano a loro stesse, ma in questo caso c’è da chiedersi se esistano e se non siano una noia mortale.
Osimhen aveva bisogno di Napoli? Qui la risposta è una e una soltanto.
Chi invece, a quanto pare, non pensa affatto che collettività senza bisogno di eroi siano una noia mortale è l’altro simbolo del trionfo azzurro: Luciano Spalletti, l’artefice, il condottiero, il navigato allenatore che finalmente ha vinto lo Scudetto dopo tanti anni, molte squadre, successi e sconfitte, spogliatoi che pendono dalle sue labbra, ma anche baruffe con capitani riottosi all’inesorabile passare del tempo (la leggenda Francesco Totti) o distratti e portati a spasso a piacimento dalle gonnelle (il Mauro Icardi della telenovela senza fine con la moglie e agente Wanda Nara). Ebbene, l’uomo al comando finalmente vince, e che fa?
Lascia.
Addirittura, pensa di stare fermo il prossimo anno, ritirandosi nella sua tenuta. Evidentemente il tedio non lo preoccupa. C’è dello spietato realismo in questa scelta. Troppo amore dato, troppe energie spese. Il vecchio lupo di calcio Luciano sa che l’anno venturo, fosse rimasto alla guida della squadra, avrebbe dovuto dare ancora di più, sempre di più, per giunta avendo (quasi) tutto da perdere. Perché questo si chiede agli eroi: superare ogni ostacolo, non importa se ogni volta più ostico, uno dopo l’altro, come macchinette generatrici di leggende.
Il fatto è che agli eroi si dimentica, di tanto in tanto, di accordare un po’ di umanità, con il relativo carico di debolezze e limiti. Spalletti no, quell’umanità l’ha rivendicata coi fatti. E da eroe ha lasciato l’arena della città.


Tra la maschera di Victor e la pelata (e la parlata di Luciano) non poteva mancare la storia dell’underdog che trionfa, del signor Nessuno che spacca il mondo. Arrivato l’estate scorsa con la nomea di talentino, come successo a innumerevoli meteore nella storia del calcio, Khvicha Kvaratskhelia ha spaccato il campionato con le sue accelerazioni, la sua fantasia e la sua anarchia creativa. E del trionfo è diventato il terzo simbolo, complice anche una immediata iper-celebrazione mediatica.
Già, perché al giorno d’oggi ogni parabola individuale viene istantaneamente mitizzata. A un paio di mesi dal suo sbarco in Serie A, Kvara era già stato ribattezzato nientemeno che “Kvaradona”, peraltro dal New York Times. Icona globale di giornalismo che di calcio non si interessa poi tanto. Ma di storie, quelle sì.
Colpisce però l’istantaneità della celebrazione, dopo una ridotta manciata di pur ottime partite del georgiano, il cui impatto con la serie A è stato semplicemente incredibile. Ma accostarlo così smaccatamente e così velocemente all’icona dell’Eroe per antonomasia, in una città come Napoli, desta comunque una certa impressione. Eppure in città nessuna levata di scudi seguì a quel titolone a stelle e strisce dell’autunno scorso, nessuna blasfemia per i tifosi che iniziavano a sognare un’annata storica. Il profumo era quello di un altro eroe e nessuno voleva spezzare la magia del momento. E così era caduto un tabù, era svanita la reverenza per il sacro e l’intoccabile, così come per la scaramanzia, se pensiamo agli striscioni già pronti e spesso esposti in città in primavera, con enorme anticipo rispetto alla certezza di conquista del campionato.
Ma così è, il conio del nomignolo “Kvaradona” è l’esempio perfetto di quell’atteggiamento che considera il mondo un luogo che ha un disperato, costante, famelico bisogno di eroi. Un bisogno che corre a ritmi forsennati come mai avevamo (forse) visto prima. E che va costantemente soddisfatto.